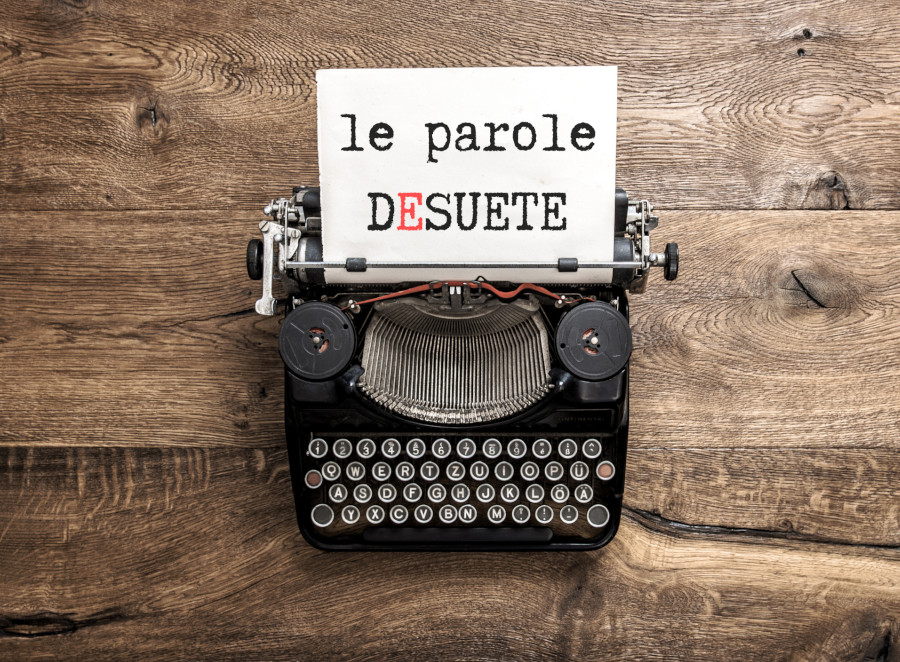5+1 parole desuete della lingua italiana

Da “anomia” a “unqua” un viaggio nel passato (da conservare) dell’italiano.
Come ogni lingua, anche l'italiano (che è ricchissimo di parole) si evolve e cresce. E come per ogni lingua anche in italiano capita che ci siano parole che si perdono, escono dall'uso comune, vengono dimenticate e poi… muoiono. Sì, perché per una parola la morte è quando nessuno la conosce, nessuno si ricorda di lei. Alcuni anni fa l'editore di uno fra i più apprezzati vocabolari della lingua italiana ha addirittura lanciato un hashtag per riportare in vita parole a rischio di estinzione: #paroledasalvare.
Ci sono diverse parole nel "dimenticatoio" (termine che designa il luogo immaginario in cui vanno a finire tutte le cose dimenticate) della lingua italiana. Ne abbiamo scelte 5, una per ogni vocale, e te le regaliamo affinché tu possa ricordarle, usarle e dar loro nuova vita.
Prima, però, c'è un'altra parola su cui merita fare un piccolo sforzo di approfondimento: "desueto". Si tratta dell'aggettivo che si lega alle parole non più in uso. Prende origine dal latino desuetus, che indica la perdita di abitudine, termine da cui derivano sia "desueto" che "dissueto". Si tratta di sinonimi ma, se proprio vogliamo trovare differenze, la prima parola può essere usata per indicare qualcosa che da molto tempo non si usa più; la seconda può indicare una persona non più abituata a fare qualcosa.
5 parole desuete della lingua italiana
- anomia
ha radici greche e indica una situazione in cui mancano leggi o regole. In ambito medico e psicologico si usa per indicare una difficoltà del linguaggio, precisamente l'incapacità di evocare i nomi di oggetti o persone. In ambito di scienze sociali si dice anomia quella condizione di smarrimento che alcune persone sperimentano quando le norme che regolano la convivenza sociale si sgretolano, perdono efficacia, ed è difficile riconoscersi in un sistema sociale che sta mutando e va alla ricerca di nuove leggi
- eristico
anche questa è una parola che ha origini nell'antica Grecia (“eristico” riporta al concetto di litigio) e viene usata per indicare un ragionamento sottile (ma non solido) che ha il solo scopo di convincere. Quando l’unico obiettivo del prendere parte a una discussione è quello di prevalere, la discussione stessa diviene battaglia e le argomentazioni finiscono per essere eristiche
- ingramagliare
significa vestirsi a lutto, cioè in maniera sobria e con tonalità scure. L'origine di questa parola è da far risalire alla parola gramalla, che in spagnolo indica una antica veste lunga fino ai piedi, da cui deriva l'italiano "gramaglia" (abito da lutto)
- obnubilare
si tratta di una parola con origini latine che è particolarmente affascinante perché significa, letteralmente "coprire di nuvole". Viene usata anche per indicare qualcuno che ha i sensi "annebbiati": una persona obnubilata è qualcuno che non ha la totale – ancorché momentanea - padronanza delle proprie facoltà
- unqua
il significato letterale di unqua è "mai". Salvo qualche uso poetico in un passato remoto della letteratura italiana, l'uso è talmente sporadico che è da considerarsi come una parola ormai vicina all'oblìo. Deriva dal latino ŭnquam.
Le parole desuete della lingua italiana: esempi di frasi
- anomia
“In quest'epoca di cambiamenti, i giovani sono in crisi, vivono in anomia (smarrimento)”
- eristico
“Abbandono la discussione, i tuoi sono ragionamenti eristici (ingannevoli)”
- ingramagliare
“Dopo la morte del suo cane visse ingramagliata (vestita a lutto) fino alla fine dei suoi giorni”
- obnubilare
“Al terzo bicchiere di vino mi sentivo obnubilato (confuso)”
- unqua
“Nei tuoi anni da marinaio unqua vedesti (non vedesti mai) una balena?”.